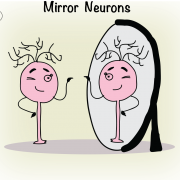LAVORO DUNQUE SONO… e davvero così?
Ciò che faccio è ciò che sono?
È una domanda che tutti, prima o poi, abbiamo rivolto a noi stessi. La maggior parte delle volte, però, la risposta è stata sepolta sotto il tappeto, in attesa di tempi migliori. Che non sono mai arrivati.
Non a caso è un tema dibattuto.
A risollevare il mio interesse è un’intervista che Good Morning America fece alla leggenda del basket Kobe Bryant, in cui il cestista raccontò di cosa avrebbe fatto una volta ritiratosi dalla pallacanestro, sottolineando l’importanza di riconoscere la “differenza tra chi sei e ciò che fai e capire che non siamo quello che facciamo“.
Sebbene sia un pensiero condivisibile relegare il #lavoro a un incomodo fra noi e le cose belle della vita, il rischio a cui andiamo incontro è banalizzare l’essere umano.
Per la maggior parte delle persone, me compresa, il lavoro viene percepito “non solo come fonte di reddito, ma anche come legittimazione sociale“, per citare Tom Fryers, docente di salute mentale pubblica all’Università di Leicester.
In una parola: #workism. Termine che si deve al giornalista americano di The Atlantic Derek Thompson, che ne ha parlato in Workism Is Making Americans Miserable.
LAVORO DUNQUE SONO
Personalmente il #workism non mi infastidisce, anche se Thompson lo usa in senso negativo.
Fin dall’infanzia siamo cresciuti con l’idea che è il lavoro a nobilitarci. Il lavoro è la priorità, l’imperativo, la strategia, la soluzione, il piacere, la filosofia alla base della nostra intera esistenza.
Senza contare che più ore di lavoro sono, in diversi contesti, un segno dello status di élite. Il tempo libero non è un privilegio, e nemmeno lo si desidera. Non c’è svago: solo tempo perso.
Per queste ragioni Thompson scrive che il #workism è un “tipo di religione, identità promettente, trascendenza e comunità“, che occupa il posto che un tempo il cristianesimo occupava nella società.
Se dedichiamo tanto tempo ed energie forse la questione è difficilmente relegabile in un articolo di giornale.
GLI ASPETTI NEGATIVI
Il #workism non è di per sé dannoso se lavorare tanto, tantissimo fa parte di un progetto personale; lo diventa quando le cose vanno male poichè i risultati possono essere emotivamente devastanti. Un progetto che fallisce, mancare una promozione o venire licenziati può rapidamente innescare un effetto domino negativo in coloro che si vedono definiti (solo) dai loro risultati professionali.
Su Harvard Business Review , la psicologa Janna Koretz ha condiviso la storia di un partner di un prestigioso studio legale che piangeva, seduto sul pavimento del bagno, quando si è reso conto di sentirsi insoddisfatto al lavoro. All’improvviso, di tutto quello che aveva conquistato, rimaneva poco o niente. “Chi sono io, se non posso più essere un avvocato di successo?”.
Anche per le organizzazioni c’è un prezzo salato da pagare se il #workism è parte integrante della cultura aziendale. Più persone vedono il loro lavoro come centrale per la loro identità, più è probabile che lavorino troppo. La ricerca mostra il danno che può derivare dal passare troppe ore in ufficio. “La produzione diminuisce drasticamente dopo una settimana lavorativa di 50 ore e precipita oltre le 55 “, ha osservato un articolo della CNBC nel 2015, citando uno studio di John Pencavel di Stanford e l’Institute of Labor Economics.
Uno degli insegnamenti che maggiormente porta a riflettere sui pericoli di fondere il lavoro con sé stessi arriva dal cofondatore di Facebook, Dustin Moskovitz. A lungo mitizzato per il suo impegno h24 – 7/7, Moskovitz oggi afferma che la sua eccessiva concentrazione sul lavoro lo ha danneggiato: “Vorrei aver dedicato più tempo ad altre esperienze che mi avrebbero aiutato a crescere rapidamente se solo avessi dato loro una possibilità. Potresti pensare: ma così facendo, Facebook non avrebbe avuto meno successo? In realtà, credo che sarei stato più efficace: un leader migliore e un dipendente più concentrato e riflessivo, oltre che meno frustrato e risentito. Insomma, avrei avuto più energia e l’avrei spesa in modi più intelligenti”.
Ora cofondatore di un’azienda di software, Moskovitz ha costruito una cultura in cui “le persone non lavorano troppo… Possiamo incoraggiare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata nella fredda e spietata ricerca del profitto. Stiamo massimizzando la nostra velocità e la nostra felicità allo stesso tempo”.
IL PROBLEMA è/e LA RISPOSTA
A questo punto una domanda sorge spontanea: come possiamo continuare a creare nuova ricchezza, inventare nuove tecnologie e progredire, trovando anche qualcosa che dia scopo, direzione e significato alle nostre vite?
Il #Workism potrebbe essere il problema e al tempo stesso la risposta.
Creare nuova ricchezza, inventare nuove tecnologie e progredire è qualcosa che dà scopo, direzione e significato. Workism è un termine peggiorativo – un aggiornamento di workaholic – usato per respingere quella che in realtà è un’idea molto convincente: che risolvere i problemi umani, costruire il futuro e semplicemente fare le cose è un’importante e significativa attività.
HOWARD ROARK E IL SENSO DEL LAVORO
Il lavoro è una necessità ineludibile. Non solo per il funzionamento della nostra economia, ma anche per il benessere delle persone.
La necessità di lavorare va molto più in profondità. Il lavoro e la produttività sono le attività essenziali della vita umana, da cui scaturisce tutto il resto. Ogni cibo che mangiamo, ogni capo di abbigliamento che indossiamo, tutti gli strumenti che usiamo per viaggiare, informarci, divertirci: niente di tutto ciò è fornito automaticamente dalla natura. Tutto deve essere prodotto. Ciò significa non solo millenni di fatica fisica, ma anche millenni di scoperte, invenzioni e creatività.
Come potrebbe questo non essere significativo? Come può l’ascesa dell’umanità dalla caverna al grattacielo – non essere vista come qualcosa che contribuisce alla identità personale e allo scopo della vita?
Forse nessuno rappresenta questo aspetto del workism meglio dell’eroe di Ayn Rand di “La fonte miracolosa”, Howard Roark. All’inizio del romanzo, spiega il motivo della sua ostinata insistenza: “Ho sessant’anni da vivere. La maggior parte di quel tempo sarà dedicata al lavoro. Ho scelto il lavoro che voglio fare. Se non ci trovo gioia, allora mi condanno solo a sessant’anni di torture“.
Successivamente, va più in profondità, ponendo l’argomento del lavoro al centro del significato della vita, in particolare in risposta a “coloro che cercano una sorta di scopo superiore, che non sanno per cosa vivere, che si lamentano di dover ‘ritrovare se stessi’”.
Il romanzo è del 1943; la crisi del significato non è una novità.
Ecco la risposta.
Roark strappò un grosso ramo da un albero, lo tenne con entrambe le mani, un pugno chiuso a ciascuna estremità; poi, con i polsi e le nocche tesi contro la resistenza, piegò lentamente il ramo in un arco. “Ora posso farne quello che voglio: un arco, una lancia, un bastone, una ringhiera. Questo è il senso della vita.”
“La tua forza?”
“Il tuo lavoro“. Gettò da parte il ramo. “Il materiale che ti offre la terra e quello che ne fai”.
Il rovescio della medaglia di trovare un significato nel lavoro è trovare un lavoro che meriti quel significato. Significa trovare un lavoro che ti interessa e che vuoi fare, piuttosto che finire dove la vita ti porta.
CONCLUDENDO
Il lavoro è un’attività centrale che occupa le nostre vite per necessità, e la maggior parte di noi riesce a trovare significato, valore e orgoglio nel farlo. Il workism non è né un’invenzione recente né una strana teoria. È la realtà effettiva di gran parte della vita umana. Faremmo molto meglio a riconoscerlo e ad abbracciarlo.
Siete d’accordo?