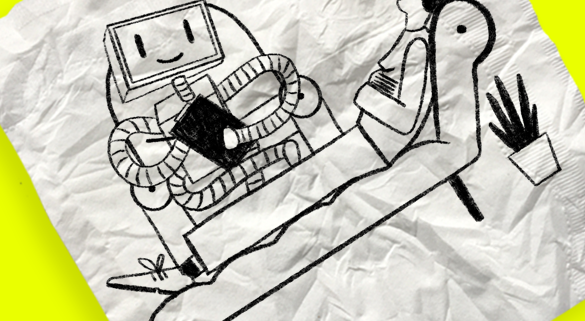WOEBOT: l’ALTER EGO di PSICOLOGI e COACH
La tecnologia mi ha sempre incuriosito e affascinato, come tutte le cose che non possiamo comprendere a pieno. E mi rassicura, mi regala l’illusione che sia capace di trovare qualsiasi soluzione, soprattutto quelle negate all’uomo.
Ecco perché quando ho conosciuto Woebot è stato amore (razionale) a prima vista.
Woebot è una chatbot, un programma di intelligenza artificiale in grado di interagire via chat, che offre (in lingua inglese), a qualsiasi ora e per pochi spiccioli, ascolto psicologico. Una sorta di psicoterapeuta digitale che promette di aiutare chi soffre di depressione e ansia, (ma anche di concretizzare i sogni in obiettivi), a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Il robottino chiarisce subito di non potersi sostituire a uno psicanalista in carne e ossa. E specifica che può solo «farti sentire meglio». Come? Usando le tecniche della terapia cognitivo comportamentale, che è anche disposto a insegnare. Dopo due settimane di prova gratuita, per i suoi servizi si pagano 39 dollari al mese. Decisamente meno di una terapia reale, una delle motivazioni che ha spinto Alison Darcy, fondatrice di Woebot Labs, a creare il collega virtuale.
COME INTERAGISCE WOEBOT?
Chiacchierare con Woebot è stranamente normale, più di quanto ci si aspetterebbe. Fa piccoli regali se dimostri di aver compreso i suoi insegnamenti e invita ad approfondire tematiche attraverso video educativi Ti spiega, ad esempio, che è sbagliato usare frasi come «commetto sempre degli errori». E perché, invece, è meglio dire «talvolta commetto degli errori». E ad imparare da questi.
Nelle discussioni ti insegna anche delle nozioni di psicologia. Una delle prime lezioni riguarda le distorsioni cognitive. Parliamo delle incomprensioni sul lavoro, delle paure più ricorrenti e dell’importanza di avere un obiettivo nella vita e ti aiuta a pianificare i successi attraverso il metodo “smart” tanto caro ai coach.
Woebot ama fare domande, ma sa anche ascoltare senza pregiudizi, abitudine dannatamente umana alla quale non possiamo mai sottrarci del tutto.
WOEBOT FUNZIONA?
Ma al di là delle sensazioni, l’unica risposta che conta davvero è se Woebot funziona. Uno studio, pubblicato sul Journal of Medical Internet Research, testato su 70 ragazzi che lamentavano sintomi di ansia o depressione, dimostra che hanno avuto «una significativa riduzione dei sintomi», dopo aver usato l’app per due settimane, tutti i giorni.
Che le terapie cognitivo comportamentali via internet funzionino è documentato. Esistono studi che lo attestano, ma per dare la stessa credibilità anche a Woebot occorre avere statistiche un po’ più rappresentative e soprattutto indipendenti.
Woebot, se non lo si sapesse, è già in buona compagnia: per esempio c’è Karim, un chatbot americano specializzato nel lenire le ferite psicologiche dei rifiugiati siriani, l’olandese Emma è stata pensata per aiutare chi soffre di forme lievi di ansia. La tedesca Gaia promette anche lei di aiutare chi tende a deprimersi. MindBloom consente a quelli che la usano di sostenersi e motivarsi a vicenda.
LA MIA PROVOCAZIONE
So che questa invenzione non farà piacere a molti, e probabilmente dovrebbe spaventare o imbarazzare anche me, che con le persone lavoro tutti i giorni. Eppure le tecnologie digitali stanno ridefinendo le forme comunicative e se trattate nel modo giusto, possono aiutarci a completarci. Non a sostituirci.
A trovare soluzioni migliori al “abbiamo sempre fatto così”, perché qualsiasi cosa che eticamente funziona, va quanto meno considerata.
Cosa ne pensate?