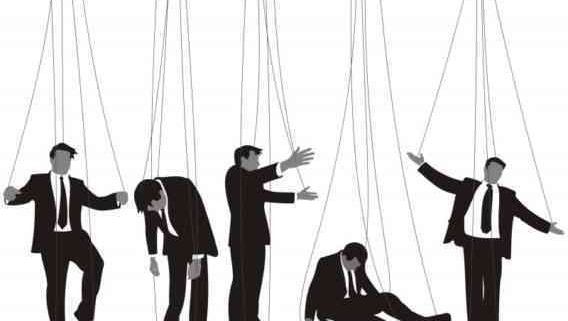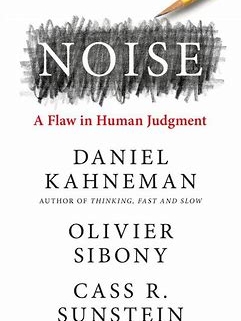Una REGINA ROSSA (Attraverso lo specchio) per rimanere COMPETITIVI
“Qui, vedi, devi correre più che puoi, per restare nello stesso posto”,
dice la Regina Rossa ad Alice, in Attraverso lo specchio, il romanzo di Lewis Carroll.
Scrittore, Carroll, capace di far diventare i suoi racconti dei classici senza tempo ma anche di influenzare Leigh Van Valen, biologo statunitense, che da quella frase estrasse una vera e propria ipotesi #evolutiva: l’ipotesi della regina rossa.
Nelle sue ricerche, Van Valen aveva notato che in nessuna situazione una specie poteva considerarsi protetta dall’estinzione. L’evoluzione è un processo continuo e tutti gli esseri viventi devono continuamente rispondere alle pressioni del proprio ambiente se non vogliono scomparire.
In sostanza, nessuna specie può permettersi il lusso di smettere di adattarsi senza correre il rischio di compromettere il proprio posizionamento competitivo e la propria sopravvivenza. Ogni essere vivente infatti, è costantemente alla ricerca di opportunità per acquisire un vantaggio e quindi l’adattamento è guidato anche dalla necessità di reagire ai cambiamenti di coloro con cui si condivide l’ambiente.
CORRERE PER RIMANERE NELLO STESSO POSTO
Nel campo della #biologia, gli organismi non decidono consapevolmente di adattarsi: un leone, osservando le antilopi, non pensa: “mannaggia, stanno correndo più veloci del solito. Devo allenarmi per migliorare il mio stato di forma.” Quello che accade in natura è che solo le antilopi più veloci riescono a sopravvivere e riprodursi. Questo metterà pressione ai leoni in quanto solo quelli più veloci riusciranno a catturare le prede e a continuare la specie.
Nel lungo periodo, la velocità media di antilopi e leoni aumenterà, poiché la pressione su prede e predatori è costante. Questa è l’essenza dell’Effetto Regina Rossa: costringere gli organismi a un adattamento continuo semplicemente per sopravvivere.
L‘equilibrio non esiste o, meglio, ci troviamo di fronte a un equilibrio dinamico. L’equilibrio c’è, ma cambia sempre. L’evoluzione è come una reazione a catena nel teatro dell’ecologia.
LA REGINA ROSSA E LA STRATEGIA AZIENDALE
L’Effetto Regina Rossa può essere utilizzato come modello per interpretare le pressioni competitive a cui sono soggette le aziende. Van Valen aveva osservato che la pressione sulle specie è costante e non connessa alla longevità: “indipendentemente da quanto una specie è sopravvissuta, l’incapacità di continuare ad adattarsi può comunque portarla all’estinzione”.
Nella competizione tra aziende, a volte correre veloci non basta neanche per rimanere fermi. Per progredire e innovare bisogna correre in maniera diversa dalla concorrenza, inventandosi nuovi mercati, cambiando le regole del gioco.
L’intensità dell’Effetto è quindi un fattore fondamentale per valutare il posizionamento di un’attività imprenditoriale, nonchè uno dei parametri chiave utilizzati da Munger e Buffett per decidere in quali aziende investire.
Secondo Munger esistono delle forze competitive distruttive (il suo modo per definire l’Effetto Regina Rossa) che nel lungo periodo mettono in pericolo la sopravvivenza di gran parte delle aziende.
Per questo Munger e Buffett hanno quasi sempre evitato settori caratterizzati da un Effetto Regina Rossa troppo intenso. Quando non hanno seguito questa regola, hanno subito perdite importanti: è il caso dell’investimento nel settore tessile, che Buffett considera uno dei suoi errori più importanti.
Tutti gli investimenti per ridurre i costi furono inutili perché anche tutti i competitor fecero lo stesso con il risultato che a ridursi furono solo i prezzi. E quindi dopo ogni giro di investimenti tutti i giocatori si ritrovarono con più soldi sul piatto e con gli stessi rendimenti anemici. Il classico esempio dell’Effetto Regina Rossa a massima potenza!
In ogni caso, per contrastare l’Effetto Regina Rossa presente in varie intensità in tutti i settori, le aziende devono sviluppare dei vantaggi competitivi, che Munger e Buffett definiscono moats, fossati, per difendersi dalle incursioni esterne. Questi fossati devono essere continuamente allargati per assicurare una protezione sostenibile nel tempo, altrimenti gli invasori troveranno, prima o poi, il modo di superarli.
Le aziende migliori, quindi, sono quelle che non solo sono in grado di costruirsi un fossato, cioè un vantaggio competitivo, ma lavorano in maniera incessante per allargarlo, cioè continuano ad adattarsi e a evolvere per far fronte alla pressione continua dell’Effetto Regina Rossa a cui sono inevitabilmente sottoposte.
ALTRI MODI PER RACCONTARE LA REGINA ROSSA
In Deep Simplicity John Gribbon descrive il principio della regina rossa usando le #rane.
Ci sono molti modi in cui le rane, che vogliono mangiare le mosche, e le mosche, che vogliono evitare di essere mangiate, interagiscono. Le rane potrebbero sviluppare lingue più lunghe, per catturare le mosche; le mosche potrebbero evolversi in un volo più veloce, per scappare.
Le mosche potrebbero sviluppare un sapore sgradevole o espellere veleni che danneggiano le rane e così via. Sceglieremo una possibilità. Se una rana ha una lingua particolarmente appiccicosa, troverà più facile catturare le mosche. Ma se le mosche hanno corpi particolarmente scivolosi, troveranno più facile scappare. Immagina una situazione stabile in cui un certo numero di rane vive in uno stagno e mangia ogni anno una certa proporzione delle mosche.
A causa di una mutazione, una rana sviluppa una lingua extra appiccicosa. Andrà bene, rispetto ad altre rane, e i geni per lingue extra appiccicose si diffonderanno nella popolazione di rane. All’inizio viene mangiata una percentuale maggiore di mosche. Ma quelli che non vengono mangiati saranno quelli più scivolosi, quindi, i geni per una maggiore scivolosità si diffonderanno nella popolazione di mosche. Dopo un po’, nello stagno ci sarà lo stesso numero di rane di prima e ogni anno verrà mangiata la stessa proporzione di mosche. Sembra che non sia cambiato nulla, ma le rane hanno lingue più appiccicose e le mosche corpi più scivolosi.
Siddhartha Mukherjee, nel suo libro vincitore del premio Pulitzer The Emperor of All Maladies, descrive la Regina Rossa nel contesto della droga e del cancro.
Nell’agosto 2000, Jerry Mayfield, un poliziotto quarantunenne della Louisiana con diagnosi di leucemia mieloide cronica, iniziò il trattamento con il Gleevec, un farmaco antitumorale specifico per quella malattia. All’inizio la risposta fu rapida e positiva. Il poliziotto si sentiva bene, in forma. Ma durò poco. Tre anni dopo, la malattia si è ripresentata e pur aumentando e aumentando ancora la dose di Gleevec, non ci fu risposta. Il cancro di Mayfield era diventato resistente alla terapia…
Si era avviata una battaglia perpetua con un combattente instabile. Quando la malattia è riuscita a rendere innocuo il farmaco, solo un nuovo trattamento di nuova generazione avrebbe potuto contrastare la leucemia.
In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la Regina Rossa dice ad Alice che il mondo continua a muoversi così velocemente sotto i suoi piedi che deve continuare a correre solo per mantenere la sua posizione. Questa è la situazione con il cancro: “siamo costretti a continuare a correre solo per stare fermi”.
CONCLUSIONI
L’Effetto Regina Rossa ci ricorda che non possiamo mai rilassarci (troppo) neanche quando abbiamo acquisito una posizione di forza rispetto ai nostri concorrenti o il contesto in cui lo caliamo: la pressione è costante e se rimaniamo fermi, prima o poi qualcuno o qualcosa troverà il modo per raggiungerci e superarci. Non è la forza che ci consente di sopravvivere nel lungo periodo, ma la capacità di adattamento.
Ps. Attenti a non confondere la Regina Rossa con la Regina di Cuori del libro precedente Alice’s Adventures in Wonderland. Le due regine condividono le caratteristiche di essere rigorose e associate al colore rosso. Tuttavia, le loro personalità sono diverse “Ho immaginato la Regina di Cuori come una sorta di incarnazione di una passione ingovernabile: una Furia cieca e senza scopo. La Regina Rossa l’ho immaginata come una Furia, ma di un altro tipo; la sua passione deve essere fredda e calma – formale e severa, ma non scortese; pedante al decimo grado, l’essenza concentrata di tutte le governanti!“