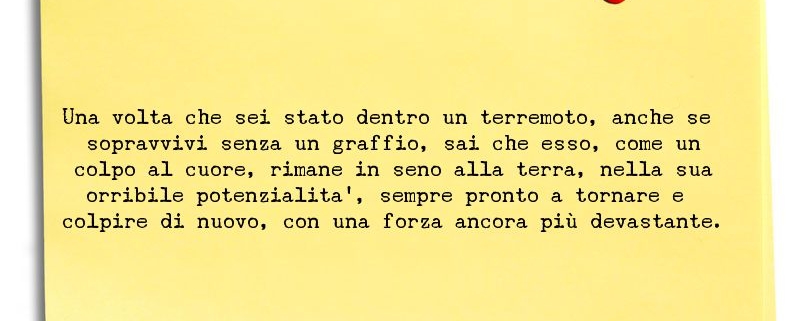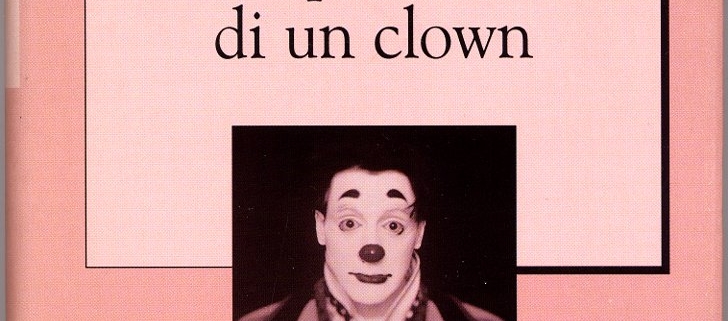CARO PRESIDENTE CONTE, TI SCRIVO…
Non si crea compliance, adesione alle norme sociali, usando la leva della paura e/o del divieto così come viene. Lo sanno anche i muri. Gli unici ancora a non saperlo, mi viene da pensare (ma vorrei essere contraddetta) sono i nostri decisori…
E’ a questo che penso da mesi, stupita che nelle varie task force non ci siano esperti e profondi conoscitori anche delle Scienze comportamentali e/o dell’economia comportamentale o di Neuroscienze applicate alla Comunicazione. Non so se i nostri governanti ignorino l’importanza di queste discipline o preferiscano starci volutamente lontani per le ragioni che si possono ben immaginare.
Su questo rifletto mentre ascolto il video discorso di Emmanuel Macron, il presidente francese, risultato positivo al coronavirus giovedì
“Sto bene, ho gli stessi sintomi di ieri: affaticamento, mal di testa, tosse secca come le centinaia di migliaia di persone che hanno convissuto o convivono con il virus. Continuerò a seguire gli affari ricorrenti anche se con un’attività un po’ rallentata. (…) Fate attenzione, tutti possiamo contrarre il virus”.
In una parola: rassicurante. Avvolgente. Empatico. Un messaggio non autoreferenziale, puntuale e descrittivo e al tempo stesso ingaggiante. Per chi mastica di bias… un buon uso del principio di riprova sociale. A tutti piace sentirsi parte di un gruppo, essere accettati e condividere preoccupazioni e speranze.
Difficile non fare un paragone, con il nostro Presidente del Consiglio e non della Repubblica (come freudianamente si lasciò sfuggire nel discorso dell’8 settembre) Conte che, quando si tratta di fare annunci, sembra ignorare le normali regole non solo delle Neuroscienze, ma della comunicazione base.
Stile dittatoriale, in un Paese democratico… la contraddizione è già evidente così… forse quel lapsus è molto più predittivo, di quanto vorremmo credere!
Entrando nel merito, difficile dimenticare le sue frasi cult:
- “non cadremo nel baratro”, quando voleva, in pieno lockdown, tranquillizzare gli italiani, fa già tristezza così senza dover aggiungere altro…
- “il governo non lavora con il favore delle tenebre”,
- “meno libertà per tutelare la salute”
In realtà, nei momenti di incertezza (che non piacciono a nessuno) servono regole chiare, indicazioni precise, coerenza e autorevolezza. Mi sembra che questi ingredienti siano mancati tutti o quasi. Chi si farebbe operare da un chirurgo che in sala operatoria prima di mettere mano ai ferri ci dicesse
“speriamo di non sbagliare approccio chirurgico, mi auspico che i miei colleghi seguano le procedure”.
Chi decide e guida, deve esprimere autorevolezza e direzione, non ulteriore incertezza.. o paure e preoccupazioni… Sperare e auspicare sono verbi che non fanno troppo bene alla nostra amigdala.
Ancor più i continui e non programmati divieti che ci vengono offerti come si fa con le caramella ai bambini ad Halloween. Non sapendo che altro fare, vieto… Non funziona neanche questo approccio: quando ci viene proibito qualcosa, la più comune delle reazioni è la reattanza, un fenomeno che consiste nel rifiuto di accettare regole che limitano i comportamenti individuali.
Quando ci si sente eccessivamente costretti in una direzione che non si condivide, l’unico risultato che si ottiene è il comportamento opposto.
Caro Conte, la prossima volta che le verrà voglia di creare un’altra task force, non ignori (per usare il suo stile comunicativo) le Neuroscienze, so che possono sembrare noiose, ma il Nobel è ancora un sigillo di sapere e autorevolezza, che piaccia o meno. Io, persone come Thaler e Kahneman le starei a sentire. E poi non dica che non l’avevo avvisata!