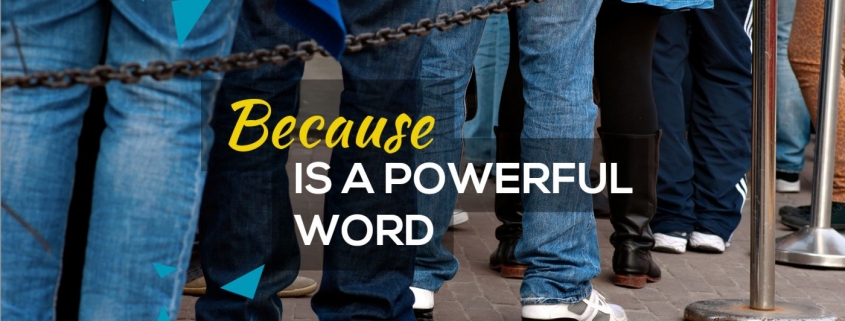“Perché abbiamo bisogno di trovare un nemico, qualcuno a cui dare la colpa dei nostri errori, delle nostre paure, dei nostri fallimenti?” – mi chiede un partner di una società di consulenza, durante una pausa caffè.
Domanda complessa di un fenomeno dilagante, dettato da stereotipi etnici e di genere che colpisce tutti trasversalmente, persino chi sarebbe chiamato a dare il buon esempio, se non altro per mandato istituzionale. Ma al di là dell’opportunismo, cosa accade nel cervello di un razzista?
Secondo la psicologia sociale il razzismo è determinato da due vizi di ragionamento: il pregiudizio e lo stereotipo. Nonostante l’accezione negativa, entrambi operano quotidianamente perché permettono di accelerare i nostri ragionamenti, facendo il minimo sforzo.
Il pregiudizio è un’opinione preconcetta che non si basa su un’esperienza diretta. Una semplice conoscenza scorretta diventa pregiudizio quando non cambia a fronte di nuovi dati.
Gli stereotipi sono descrizioni generalizzate di gruppi di persone che si basano su alcune caratteristiche salienti, positive o negative. A questi gruppi, riconoscibili per caratteristiche fisiche, sociali, culturali ecc.., vengono associati valori, motivazioni e comportamenti in modo così netto che diventa impossibile considerare la singola persona nella sua unicità.
Uno dei problemi fondamentali dello stereotipo è che, come il pregiudizio, si modifica con molta difficoltà. Ciò accade anche perché vengono create le condizioni affinché queste convinzioni si avverino. Se pensiamo che una persona sia fredda e ci relazioniamo con lei a nostra volta in modo freddo, il nostro interlocutore sarà portato a comportarsi di conseguenza avvalorando la nostra previsione. La generalizzazione permette di sapere come comportarci anche in situazioni ignote.
I razzisti sono empatici?
I neuroscienziati dell’Università di Bologna hanno testato la reazione a immagini dolorose relative al proprio e all’altro gruppo etnico, confermando che a fronte del dolore altrui si attivano automaticamente gli stessi circuiti cerebrali collegati alla percezione di quel dolore, come se l’osservatore lo stesse provando sulla propria mano. La risposta automatica però non si è attivata nel caso di individui appartenenti ad un diverso gruppo etnico. E quanto più i volontari avevano dimostrato un atteggiamento xenofobo, tanto più i loro cervelli si erano dimostrati indifferenti alla sofferenza altrui.
«La ricerca dimostra che la scarsa empatia, cioè la capacità di condividere e comprendere i sentimenti e le emozioni altrui nei confronti di persone di diverso gruppo etnico, è correlata al pregiudizio razziale inconscio dell’osservatore», ha spiegato Alessio Avenanti, coordinatore della ricerca.
Ma se il problema più che di mancata empatia fosse dovuto a una incapacità di immedesimazione?«Proprio per sgomberare il campo da questo sospetto, abbiamo introdotto nell’esperimento anche una mano viola, ma alla vista di un ago conficcato sull’arto di colore viola tutti i volontari hanno mostrato invece un atteggiamento empatico».
In sostanza i ricercatori hanno ripetuto l’esperimento con immagini di mani artificialmente colorate di viola, percepite come estremamente strane e non familiari da entrambi i gruppi e il risultato è stato sorprendente: i due gruppi hanno manifestato empatia nei confronti del dolore della mano viola, nonostante la sua peculiarità, e nonostante la mano viola mostrata ai bianchi fosse quella di un nero e viceversa.
Ciò suggerisce, che non è tanto il diverso aspetto a determinare la differenza di risposta, bensì il significato culturale che viene associato.
Il razzismo ci aiuta a sopravvivere?
La psicologia evolutiva, che spiega i comportamenti umani come comportamenti mantenuti dai nostri antenati ad oggi esclusivamente perchè utili alla sopravvivenza, ci dice che il razzismo era prevalente poiché era vantaggioso, per i primi esseri umani, privare altri gruppi di risorse.
Probabilmente, non avrebbe fatto bene ai nostri antenati essere altruisti e permettere ad altri gruppi di condividere le loro risorse: ciò avrebbe solo diminuito le possibilità di sopravvivenza. Soggiogare e sopprimere altri gruppi aumentava il loro accesso alle risorse. Tuttavia, possiamo ritenere che lo sviluppo che impregna la nostra civiltà sia ben lontano da allora e la nostra cultura, aperta al nuovo ed al costante cambiamento, debba tenerci lontani da fenomeni come il razzismo.
E se invece il razzismo fosse solo un meccanismo di difesa psicologica?
Una visione alternativa è che il razzismo e tutte le forme di xenofobia non abbiano una base genetica o evolutiva ma rappresentino un meccanismo di difesa psicologica generato da sentimenti di insicurezza e ansia.
Secondo la teoria della gestione del terrore, la motivazione di questi comportamenti è migliorare il senso di importanza o valore di fronte alla morte, o di acquisire un senso di sicurezza o appartenenza, come una modalità di protezione contro la minaccia della mortalità. Il razzismo potrebbe quindi essere una risposta simile ad un senso più generale di disagio o inadeguatezza. Ma la comune ed universale caducità della vita umana dovrebbe unirci in un’unica razza: l’uomo.
E se il nemico fossi io?
Come spesso accade, è più semplice vedere il problema fuori o nell’altro. Nascondersi dietro a giustificazioni e motivazioni di vario genere. La riflessione che dovrebbe scaturire da tutto ciò è quanto sia controproducente farsi la guerra, alimentare odi razziali. La storia ci ha insegnato cosa può generare tutto questo. È vero che la storia si ripete ciclicamente, ma serve anche a non ripetere gli stessi errori, serve a ricordare di quando anche noi tentavamo la fortuna.
Quindi per rispondere alla domanda di apertura… di fatto non c’è più ragione di trovare un nemico. Ma, si sa, alle abitudini soprattutto a quelle cattive, è difficile sottrarsi…