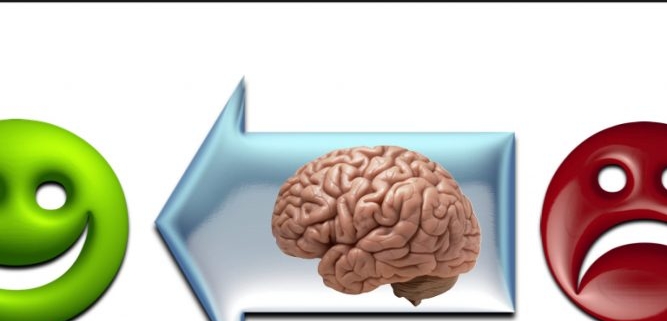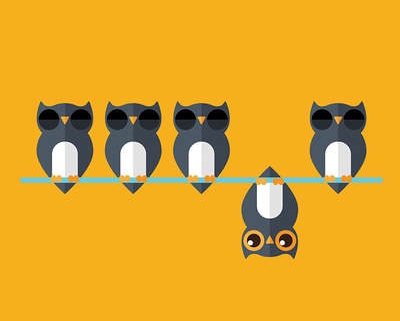“Carne: abbiamo una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto intriso, impanato. Altrimenti pesce: abbiamo rombo grasso grasso, oppure baccalà porchettato intriso, unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro”.
E’ così che Roberto Benigni, nelle vesti di un cameriere, presenta a un importante cliente entrato al ristorante in orario di chiusura, il menù. Una tortuosa lista di cibi, sapendo però che in cucina c’è solo salmone e insalata. Ma il modo in cui snocciola una dopo l’altra le diverse alternative, orienterà il cliente verso l’unica soluzione disponibile: il salmone.
Era il 1999, nelle sale usciva La vita è bella e di Nudge ancora non si parlava. Eppure questo simpatico esempio ben rappresenta la strategia che diciotto anni più tardi regalerà il Nobel per l’economia a Richard Thaler, il papà dei nudge.
LE SPINTE GENTILI
Se nel film, Benigni, si trova costretto a orientare il cliente, per forza di cose, verso l’unica soluzione possibile, i Nudge hanno un obiettivo meno commerciale e più funzionale al benessere individuale e collettivo sia in termini di salute, soldi e sia di felicità: aiutarci a preferire l’opzione migliore fra le diverse alternative possibili ma senza sforzo e fatica.
I nudge sono infatti un modo di pensare, una strategia pensata per rendere semplici scelte complesse.
In italiano la parola nudge può essere tradotta come spinta gentile ed è un approccio tutt’altro che casuale, accettato anche dai più scettici, perché validato da poderose ricerche scientifiche.
Quando ci troviamo a prendere una decisione, la maggior parte delle volte lo facciamo affidandoci più al nostro istinto che alla nostra razionalità. Se fossimo totalmente razionali, probabilmente sceglieremmo sempre la dieta giusta, il programma di allenamento più funzionale ai nostri obiettivi, non fumeremmo, non consumeremmo alcolici, non consulteremmo lo smartphone mentre siamo alla guida, valuteremmo nel dettaglio pro e contro di un’eventuale offerta di lavoro, scegliendo infine quella, sulla carta, meno rischiosa per noi e con i benefici più grandi. E ci innamoreremmo solo dopo aver attentamente vagliato ogni alternativa.
Ma non è così che ci comportiamo nel quotidiano. Siamo facilmente influenzabili, cediamo alle tentazioni e, sappiamo che al cuor non si comanda: non è possibile scegliere sempre e solo l’opzione migliore. Anzi, soprattutto in amore spesso andiamo in tutt’altra direzione… per non parlare della nostra capacità analitica quando parliamo della nostra squadra sportiva… del cuore.
È così che, per far sì che le persone prendano decisioni migliori – per il proprio benessere in primis, ma anche per la società in generale – alle volte serve loro un piccolo aiuto, una “spintarella”, un nudge appunto.
METTI UNA MOSCA IN AEROPORTO
Hai mai sentito la storia della mosca nei bagni dell’aeroporto di Amsterdam?
E’ stato sufficiente applicare l’adesivo di una mosca in ogni orinatoio maschile dell’aeroporto di Schiphol per far sì che la quantità di urina finita sul pavimento diminuisse dell’80%. Un dato che si è tradotto in una minore necessità di interventi di pulizia dei bagni e, di conseguenza, un significativo risparmio sui prodotti di disinfezione e detersione. Un effetto domino che ha portato enormi benefici all’aeroporto e ai suoi dipendenti in primis e ai passeggeri che dovevano utilizzare i bagni, poi. Non è un caso che le mosche si trovino oggi in molti altri bagni pubblici in giro per il mondo.
Le nostre scelte non avvengono nel vuoto: scegliamo sempre all’interno di contesti e architetture ben definite, anche se non ne siamo troppo consapevoli. E il modo in cui questi ambienti sono progettati influenza in modo evidentissimo le nostre decisioni, spingendoci in una direzione piuttosto che un’altra.
BANCHE E SCONTRINI
Qualche anno fa alcune banche spostarono il pulsante per richiedere lo scontrino, dopo un prelievo al bancomat, dall’angolo in basso a destra a quello in basso a sinistra dello schermo. Migliaia di euro buttati al vento? Assolutamente no.
Questa semplice modifica ha consentito alle banche di risparmiare milioni e milioni di scontrini, di carta e toner. Come?
La morfologia del nostro corpo, il nostro essere destrimani nella maggioranza dei casi, ci porta a scegliere più frequentemente un’opzione se questa si trova a destra dello schermo, così come a prestare più attenzione alle pagine dispari di un giornale, quelle che si trovano sulla destra. Le opzioni sono sempre lì a disposizione (selezionare “sì”, oppure “no” per richiedere o meno lo scontrino), non scappano, ma il modo in cui sono presentate, ci spinge a preferirne una piuttosto che un’altra.
Per risparmiare l’Istituto bancario poteva fare altre scelte, come quello di non erogare più scontrini, o farli pagare, ma in questo modo non sarebbe stato un nudge. I nudge infatti non vietano o riducono le scelte, ma presentano le alternative più funzionali al nostro benessere, al nostro portafoglio e per l’ambiente in modo che sia più facile sceglierle. La banca ha scelto di modificare l’architettura di quella scelta specifica, lasciando ai pasionari dello scontrino, la possibilità di continuare a richiederlo, ma spingendo in modo gentile gli altri, a richiederlo meno di frequente o solo quando è strettamente necessario. Se ci pensate bene, la maggior parte delle volte che lo richiediamo, finiamo poi con il gettarlo prima ancora di esserci allontanati dallo sportello.
I nudge ci lasciano liberi di scegliere l’opzione che preferiamo, ma rendono più attrattiva l’alternativa maggiormente conveniente e funzionale al nostro benessere, al nostro portafoglio, alla nostra salute, alla nostra produttività, alla nostra felicità e al pianeta.
SCELTE CHE VALGONO UNA VITA
Una delle spinte maggiormente efficaci per promuovere comportamenti virtuosi è l’utilizzo strategico dell’opzione di default. Un caso esemplare è quello della donazione di organi.
Se confrontiamo la percentuale di donatori di organi nei diversi Paesi europei, si vede che questa non è influenzata dalle opinioni individuali o dalla cultura di appartenenza, ma dalla modalità con cui è strutturato il modello di adesione al programma di donazione. Nei Paesi in cui il cittadino deve fornire un consenso esplicito per donare gli organi, la percentuale di donatori risulta molto bassa. Di contro, nei Paesi in cui il cittadino è automaticamente incluso nel programma di donazione e, al contrario, il dissenso alla donazione deve essere fornito attivamente, la percentuale di donatori è al di sopra del 90%.
Applicare l’opzione di default significa impostare un’opzione che verrà scelta automaticamente, a meno che le persone scelgano attivamente di comportarsi in modo diverso. Nella vita quotidiana la troviamo ad esempio, negli smartphone e nei dispositivi digitali, venduti con impostazioni predefinite che possiamo scegliere o meno di cambiare. I sensori di movimento sono semplici strategie per evitare sprechi di energia: fanno in modo che la luce si spenga automaticamente ogni qualvolta il sensore non rivela la presenza di persone nell’ambiente. In questo modo, i rilevatori di movimento creano l’equivalente di un valore predefinito.
Così come le impostazioni del computer spengono l’apparecchiatura quando non è in uso dopo un lasso di tempo stabilito. Carte di imbarco e badge per congressi, come altri strumenti di identificazione, possono essere sostituiti nelle finalità da smartphone e tablet e stampati solamente su richiesta. La copia elettronica della fattura è ormai divenuta la regola e quella cartacea un optional su richiesta. Sempre più spesso sono offerti incentivi con punti premio sulle carte fedeltà per acquisti effettuati senza fornitura di imballaggio nei supermercati e nel circuito del piccolo commercio.
ABBONARSI DI DEFAULT
Molti abbonamenti vengono rinnovati automaticamente a meno che non si decida attivamente di annullare l’iscrizione. Questa stessa scelta può essere posta in due modi differenti: allo scadere dell’abbonamento è possibile rinunciare all’offerta, per non ritrovarsi abbonati automaticamente; oppure, è possibile esplicitamente richiedere di continuare ad aderire. Queste due opzioni, sono logicamente equivalenti, ma a causa della nostra passione per la scelta di non scegliere, tenderemo a non modificare la nostra adesione iniziale: ci troveremo quindi, nel primo caso, iscritti, mentre nel secondo caso non iscritti. Per questo le imprese, in questi casi e in molti altri simili, preferiscono porre le questioni nella seconda forma. Perché così non scegliamo e finiamo per pagare beni e servizi dei quali avremmo fatto tranquillamente a meno. Ma in questo caso non stiamo parlando di nudge ma di sludge!
NUDGE VS SLUDGE
Gli sludge (una parola inglese che significa, non a caso, fango), a differenza dei nudge presentano opzioni di scelta che avvantaggiano chi li propone e scoraggiano ad attuare comportamenti che invece sono nell’interesse della persona, come reclamare un rimborso, cancellarsi da una newsletter e fare reclamo, come ben dettaglio nel libro “Nudge Revolution, la spinta gentile per rendere semplici scelte complesse”.
Sebbene possano sembrare simili, i nudge rispetto gli sludge cercano di incoraggiare il cambiamento per favorire scelte virtuose, per il nostro benessere, il nostro portafoglio, per la nostra felicità, produttività e per il pianeta. Se sei in dubbio, chiediti quanto sia semplice e libera la tua scelta e saprai subito se ti trovi di fronte a un nudge o a uno sludge.
Architettare dei nudge, non è complesso. Spesso infatti sono sufficienti piccole modifiche al contesto per ottenere grandi risultati. Un esempio? Sostituire in azienda i dispenser contenenti merendine e cibo ipercalorico con contenitori trasparenti con frutta fresca e noci ben visibili. Banale? Decisamente… Eppure questo piccolo accorgimento adottato negli uffici di Google a New York, ha permesso di ottenere risultati impressionanti, come ridurre del 30% le calorie totali consumate dai dipendenti, eliminare una percentuale di grasso del 40% negli snack; indurre i dipendenti a consumare 3,1 milioni di calorie in meno in sole 7 settimane di esperimento.
Rendere semplici scelte complesse dunque si può, con i Nudge!
https://magazine.darioflaccovio.it/2019/11/14/nudge-questi-sconosciuti-strategie-per-rendere-semplici-scelte-complesse/