SOLDI, PREMI E POLPETTE… NON SONO SPINTE GENTILI. RIFLESSIONI ESTIVE ANALIZZANDO SOLUZIONI POCO STRATEGICHE
Ci stanno provando in tutti i modi a convincere gli indecisi a vaccinarsi. Ma nonostante in tanti nominino le spinte gentili, soldi, premi e polpette hanno ben poco a che fare con i Nudge.
IN GIRO PER IL MONDO
In Serbia ogni cittadino che si vaccina riceve in cambio 25 euro. Negli Stati Uniti, Joe Biden ha chiesto agli Stati di offrire 100 dollari per ogni nuovo vaccinato, e rimborsare tutte le imprese che hanno concesso permessi retribuiti ai loro dipendenti per vaccinarsi.
Lo stato dell’Ohio ha offerto a ogni vaccinato la possibilità di partecipare a un’estrazione con in premio un milione di dollari. Il governatore della California ha lanciato la lotteria in denaro Vax for the Win, con un premio finale di un milione e mezzo a 10 fortunati nuovi vaccinati.
A Detroit sono stati regalati 50 dollari a chi portava una persona a farsi vaccinare e in West Virginia ogni vaccinato, ha ricevuto un buono risparmio da 100 dollari. A New York sono stati regalati biglietti per concerti, partite di basket, corse gratuite in metro e in treno per i pendolari. Nel New Jersey vengono regalate pinte di birra, nello stato di Washington spinelli.
In Russia, le autorità hanno distribuito cinque auto a settimana in un’estrazione a premi a cui ha partecipato solo chi poteva dimostrare di aver fatto almeno una dose di vaccino.
In Libano, Uber ha offerto due corse gratuite fino a 40.000 LBP (poco meno di 50 euro) ciascuna, per viaggiare da e verso i centri vaccinali.
In Romania, il governo ha consegnato ai nuovi vaccinati panini con salsiccia.
Ai londinesi, oltre a usufruire dei trasposti gratuiti per recarsi nelle sedi vaccinali, è stata data la possibilità di vincere biglietti per la finale degli Europei di calcio.
In Asia sono stati distribuiti premi in cibo. In Indonesia, una gallina viva, nelle Filippine sono state messe in palio mucche e riso. Nella periferia di Pechino vengono regalate uova agli ultra sessantenni che hanno completato il ciclo vaccinale.
A Hong Kong, ci sono in palio lingotti d’oro, Rolex di diamanti, un buono spesa di centomila dollari e una casa da oltre un milione e quattrocentomila dollari.
In Grecia viene invece offerto un buono da 150 euro ai giovani fra i 18 e i 25 anni che si vaccina. A Praga per i dipendenti statali che si vaccinano ci sono due giorni di ferie retribuite in più.
C’E’ CHI PREMIA E CHI PUNISCE
C’è chi invece ha scelto punizioni anziché premi. A Giacarta ci sono multe fino a cinque milioni di rupie (300 euro) per le persone che non si immunizzano. In alcune zone dell’India non si servono liquori a chi non dimostra di essere vaccinato.
Gli Emirati Arabi limitano le partecipazioni a eventi live, attività sportive artistiche e culturali. In Arabia Saudita non si può entrare nei centri commerciali, in Kazakistan niente bar, cinema e aeroporti. Nelle Filippine i cittadini possono optare tra: Il vaccino o il carcere[1].
Il Cremlino ha affermato che le persone non vaccinate potrebbero non accedere al posto di lavoro, non escludendo discriminazioni.
E L’ITALIA?
Anche da noi le proposte si differenziano.
Nel Lazio ci si può spostare gratuitamente con Uber che mette a disposizione due corse verso e da i centri vaccinali. Nel Messinese, la Coldiretti regala una bottiglia di Siccagno di Valledolmo (passata di pomodoro).
In Piemonte ci sono incentivi per i medici di base che riescono a convincere i propri utenti. Se il 90% di questi risulterà vaccinato entro il 15 settembre, riceveranno un compenso di 2 euro in più per assistito e di 1 euro e mezzo se la percentuale si fermerà tra l’87 e l’89,99%. La Ausl di Bologna riconoscerà un premio ai pediatri che convinceranno il 70% dei loro giovani pazienti a vaccinarsi.

UN PO’ PIU’ COMPLICATO DI COSI’…
Perfetto.
Anche no!
Distribuire soldi come se piovesse, non è un nudge (i nudge per essere tali non prevedono né incentivi economici né disincentivi). Come è già accaduto nel 2005, in Perù, quando si è voluto affrontare il problema delle diseguaglianze e frenare la povertà. E il governo ha lanciato i conditional cash transfer (cct), la versione nazionale degli Juntos: sussidi monetari condizionati che prevedevano pagamenti mensili di 100 soles in favore di genitori poveri, perlopiù madri. Per non perdere il sussidio, le donne dovevano assicurarsi che i figli frequentassero l’85% delle lezioni scolastiche in un anno e che si sottoponessero regolarmente a controlli medici e nutrizionali.
«In paesi come il Brasile, i cct sono stati importanti nell’accesso all’istruzione e nella conseguente riduzione delle disuguaglianze», spiegò la scelta Branko Milanovic, a lungo capo economista alla Banca mondiale[2]. Eppure i cct non sono la panacea, come dimostrano le voci critiche, tra cui quella del premio Nobel per l’economia Angus Deaton che ha evidenziato la loro incapacità di ridurre la povertà in via permanente[3]. Tuttavia questi programmi, complessivamente poco costosi per le finanze pubbliche (cifre tra lo 0,04 e lo 0,8% del Pil), continuano a essere molto popolari: nella sola America Latina si contano 129 milioni di beneficiari.
Al di là della loro presunta o reale efficacia, che lasciamo misurare agli economisti di mestiere, i cct sono incentivi economici e per questo ben lontani dalle politiche di nudging.
Un sussidio non può essere un nudge, come non lo è una multa e neppure una condanna alla prigione. Senza contare che gli incentivi economici distribuiti con questa leggerezza, sollevano un interrogativo etico e discriminatorio: i benestanti non saranno di certo spinti a vaccinarsi per soldi mentre gli svantaggiati subiranno una pressione non indifferente. Senza contare che nel medio – lungo termine diventano demotivanti. E quindi inefficaci.
Senza voler aprire una diatriba neuroetica, è impossibile non guardare ai dubbi che il denaro inevitabilmente solleva: l’incentivo economico non può che alimentare la cultura del sospetto. Non dimentichiamoci che è il bene comune e la protezione ai più fragili che dovrebbe spingere verso la vaccinazione.
Ecco perché più che gli incentivi, ci sono altre strategie a cui si potrebbe e dovrebbe ricorrere. La moral-suasion: incentrata su argomenti attrattivi, anzichè costrittivi e la spinta gentile, capace di rendere facili scelte complesse. Non obbligando, ma creando contesti che, senza togliere la libertà, rendono le decisioni più agevoli e funzionali.
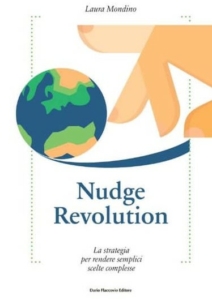
CONTESTO
Non ovunque e non sempre è facile vaccinarsi. Spesso è più un percorso a ostacoli che una via di uscita: comunicazione confusa e contraddittoria, difficoltà a prenotarsi o impossibilità a scegliere quando farlo, o a spostare l’appuntamento, luoghi spesso scomodi o difficilmente raggiungibili se non si è automuniti, mancanza di chiare informazioni su possibili effetti collaterali e un’assistenza post vaccinazione latitante. Lo dico per esperienza diretta.
Senza contare che chi si occupa delle campagne di sensibilizzazione, poco o nulla sa di spinte gentili ed economia comportamentale. E nemmeno ci pensa a consultare gli esperti del settore.
Più che regalare bibite, biglietti della lotteria e qualche banconota, sarebbe più utile investire il denaro nel prelevare a domicilio persone con problemi di mobilità o affette da fragilità, predisporre équipe che portino la vaccinazione a domicilio, un’assistenza post vaccino quando necessaria, numeri verdi dove gli operatori rispondono in modo diretto e non costringano ad attese infinite senza nessuno che si faccia carico del problema. O ancora, facilitare la vaccinazione di quei lavoratori saltuari e che hanno paura di perdere giorni di lavoro in caso di avventi avversi o problematiche post vaccino[4].
Insomma ci sono molti modi per usare il denaro. E a parità di budget, ricorrere ai Nudge (non come azione estemporanea ma come policy) porterebbe maggiori benefici rispetto ai compensi economici, mitigando o eliminando i sospetti e rafforzando la fiducia nel sistema sanitario pubblico.
FIDUCIA
La fiducia, ricordo, non si può comprare e gli incentivi possono alimentare dubbi sulle reali intenzioni delle istituzioni scientifiche. Un studio del 2020, condotto in 19 paesi utile a determinare i tassi di accettazione e i fattori che influenzano la propensione a vaccinarsi, ha mostrato come in realtà il 71,5% dei partecipanti sarebbe propenso al vaccino e il 48,1% ha riferito che accetterebbe la raccomandazione del datore di lavoro nel farlo. Le differenze nei tassi di accettazione variavano da quasi il 90% (in Cina) a meno del 55% (in Russia). Gli intervistati, a prescindere dalla nazionalità, che segnalano livelli più elevati di fiducia verso il proprio governo, hanno maggiori probabilità di ì vaccinarsi[5].
Tenendo conto di questi dati, gli incentivi difficilmente sono la soluzione. Se non per ridurre la procrastinazione, secondo gli studi dei premi Nobel per l’economia Duflo e Banerjee, e aumentare la percentuale dei vaccini dal 18 al 39%[6]. Un costo che è sicuramente giustificato.
Non c’è dunque una soluzione univoca. E ciò che realmente funzionerà lo si vedrà nel tempo. Intanto, non dimentichiamoci che i Nudge per quanto allettanti andrebbero applicati da chi li conosce per davvero. Non è una moda. E’ una strategia. Da Nobel. I soldi, e la letteratura scientifica lo dimostra, non sono così efficaci come ci piace pensare, benchè sia una soluzione sicuramente semplice e rapida…
FONTI
[1] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-duterte-threatens-those-who-refuse-covid-19-vaccine-with-jail-2021-06-21/
[2] Fiszbein A., Schady N., et al., Conditional Cash Transfers reducing present and future poverty, The World Bank report, 2009.
[3] Deaton A., Instruments, Randomization, and Learning about Development, Journal of Economic Literature, Vol. 48, N. 2, June 2010, pp. 424-55.
[4] https://www.nytimes.com/2021/07/09/nyregion/free-doughnuts-arent-going-to-boost-vaccination-rates.html
[5] Lazarus, J.V., Ratzan, S.C., Palayew, A. et al. A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine. Nat Med 27, 225–228 (2021).
[6] https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28726/w28726.pdf



