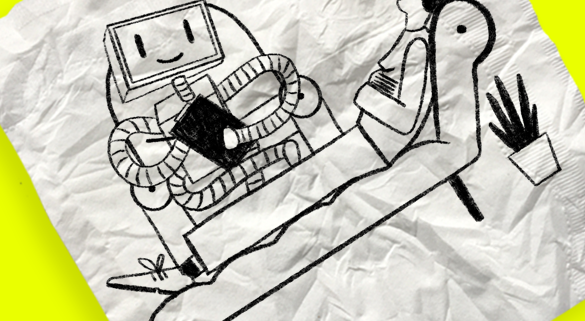QUANTO è FACILE DIVENTARE NAZISTI: l’esperimento che insegna come l’Olocausto sia potuto accadere…
“Come ha potuto il popolo tedesco, aver ignorato ciò che stava succedendo agli ebrei”?
E’ la domanda, tutt’altro che ovvia, che fece uno studente al professore di Storia Ron Jones nel 1967.
“Come hanno potuto cittadini, ferrovieri, insegnanti, medici sostenere di non sapere nulla sui campi di concentramento e sui massacri? Come hanno potuto persone i cui vicini di casa o addirittura i cui amici erano cittadini ebrei affermare che semplicemente non erano presenti quanto tutto ciò è accaduto”?
Il professore, per rispondere in modo approfondito alla domanda, decise di condurre un esperimento, conosciuto come la terza onda, e mostrare ai propri studenti, tramite l’esperienza, come può essere stato possibile che una società libera si trasformasse in un regime fascista.
LA DISCIPLINA. L’esperimento ebbe inizio un lunedì, durante il quale il professor Jones spiegò uno dei concetti cardine del nazismo: la bellezza che sta dietro la disciplina, la perseveranza, il controllo e il trionfo. Così invitò gli studenti a tenere una posizione utile a mantenere la concentrazione e rafforzare la volontà: schiena dritta, mento verso il basso, piedi dritti e ben piantati al pavimento. Gli studenti assimilarono rapidamente i nuovi parametri e Jones si chiese fino a che punto sarebbe stato in grado di portarli. Introdusse, quindi, nuove norme, come l’esigenza di rivolgersi a lui chiamandolo “Signore”, o l’obbligo di mettersi in piedi e fare un passo in avanti ogni qualvolta si volesse parlare in classe. La cosa curiosa fu che la produttività del gruppo aumentò sensibilmente: gli alunni più passivi, improvvisamente, si dimostrarono più interessati e partecipativi. Tutti sembravano rispondere positivamente.
IL SENSO DI APPARTENENZA. Il secondo giorno, il professor Jones parlò ai ragazzi dell’importanza di appartenere a un gruppo e inventò storie per rafforzare la sua idea. Gli alunni si mostravano compiaciuti; sembravano capire sempre di più il sentimento di appartenenza a un gruppo. Alla fine, il professore inventò un saluto con la mano che solo i membri potessero riconoscere: fu quello il momento in cui altri studenti vennero a sapere della nuova “comunità” e richiesero di entrarvi.
IL MOMENTO DELL’AZIONE. Il mercoledì venne creata una tessera obbligatoria per poter appartenere al gruppo della Terza Onda e più di 200 studenti chiesero di essere ammessi. Si progettò anche un rito d’iniziazione, con il quale i nuovi adepti dovevano giurare fedeltà ai principi del gruppo; inoltre, vennero tutti avvisati sulla necessità di vigilare gli altri, affinché non infrangessero le regole. Non era passato molto tempo che già cominciarono ad apparire le prime accuse: c’erano molte spie e la confusione era totale. Gli alunni che prima erano tra i più attivi, ora si mostravano disorientati e passivi; coloro che precedentemente erano isolati, improvvisamente, si integrarono nel gruppo senza problemi. Persino il Preside della scuola iniziò ad usare il saluto della “Terza Onda”.
L’ORGOLIO. Il giovedì, il professor Jones arrivò in classe e trovò un gruppo di 80 alunni completamente silenziosi e attenti a ciò che lui avrebbe detto. Il professore parlò loro dell’orgoglio nazionale, dell’importanza di rendere il paese la migliore nazione del pianeta; poi li invitò a una riunione pubblica, esclusiva per i membri della Terza Onda, in cui un candidato alla presidenza avrebbe esposto un programma di governo per la nazione. Tutti erano entusiasti e iniziarono a preparare le attività senza obiezioni.
LA SCOPERTA. L’ultimo giorno dell’esperimento ebbe inizio con i preparativi della manifestazione. Nell’auditorium, Jones salutò i suoi allievi, che gli risposero con il gesto concordato. In seguito, Jones accese un televisore, in modo che tutti conoscessero il leader tanto atteso. L’immagine rimase in bianco e nero; poco a poco cominciò a diffondersi un sentimento di angoscia e calò un lungo silenzio di delusione. Fu in quel momento che Jones prese il microfono e disse: “Ascoltatemi con attenzione, ho una cosa importante da dirvi. Non c’è nessun leader. Non c’è nessun movimento nazionale chiamato la Terza Onda. Siete stati usati e manipolati: non siete migliori dei tedeschi che hanno aderito al nazismo che avete studiato.”
Proiettò poi un film sul Terzo Reich. Alcuni dei ragazzi si misero a piangere, altri semplicemente si alzarono e se ne andarono in silenzio, delusi.
A seguito di questo esperimento Jones fu allontanato dalla scuola, dei ragazzi non si seppe più nulla, tranne di alcuni che fondarono molti anni dopo un sito a testimonianza e in ricordo di quanto accaduto in quel lontano 1967 dove dei giovani studenti capirono come l’Olocausto era potuto accadere…