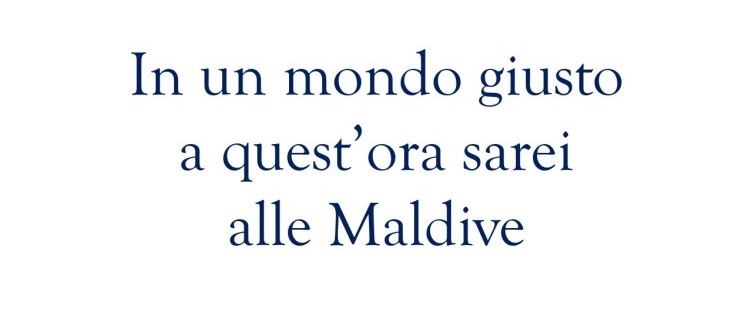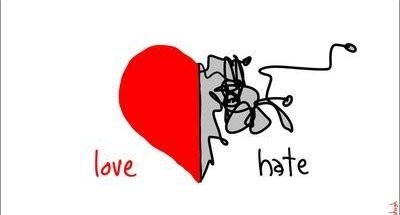“RENDERE il FAMILIARE STRANO e lo STRANO FAMILIARE” per facilitare il CAMBIAMENTO (in azienda)
Un #paradosso. Comodo, tranquillizzante e fallimentare, quello di reiterare vecchi schemi, #abitudini e #strategie, con la convinzione che si otterranno risultati diversi.
Non dico sia semplice, riuscire a riconoscere le routine consolidate, così come non lo è adattarle al nuovo a cui aspiriamo.
Fra le #strategie che possono venire in aiuto, una è rendere il familiare strano e lo strano familiare.
RENDERE IL FAMILIARE STRANO E LO STRANO FAMILIARE
Si tratta, a grosso modo, di vestire i panni dell’antropologo: mettere in discussione e capovolgere le cose, interessarsi a come la #cultura si esprime, diventare curiosi delle routine quotidiane (come viene svolto il lavoro) per poi modificarle, anziché lanciare grandi e faticosi programmi di cambiamento.
Come ha fatto quell’AD, il cui primo intervento trasformativo è stato togliere, durante la convention annuale, il ruolo/titolo gerarchico sotto il nome dei partner senior sul badge dell’evento. Il primo passo di un piano che ha visto poi trasformare i processi di produzione affinchè fossero più in linea con il cambiamento sociale e i progressi tecnologici.
Per raggiungere questo #obiettivo, e per realizzarlo rapidamente, sapeva di dover rimuovere la power-distance culturale che esisteva tra i livelli organizzativi e che, fra le altre cose, non consentiva ai più giovani di contribuire a un nuovo modo di pensare.
Rendere ciò che è sempre stato familiare (sapere chi è chi in linea gerarchica), strano (perché dovremmo farlo?!) può generare ansia e attivare le routine difensive che l’accompagnano – al fine di continuare a fare ciò che si è sempre fatto.
Fare ciò che sembra strano (le persone non si offenderanno se il loro titolo non è evidente?!) ossia la cosa più ovvia (ho solo bisogno di presentarmi), può provocare disturbo, fastidio e resistenza.
La #familiarità ha uno scopo: regalarci serenità e sicurezza. Le #abitudini ci permettono di agire senza pensare, peccato che ci impediscono di vedere le cose da nuove prospettive.
Troppo presi dalla nostra storia di come è il mondo e come dovrebbe funzionare, finiamo per non considerare scenari diversi da quelli noti.
APOLLO 8
Un po’ come è successo agli astronauti della missione Apollo 8, e brillantemente narrato in Overview Effect: gli astronauti pensavano che sarebbero andati sulla luna per saperne di più (della luna). In realtà, la cosa più importante che il viaggio sulla luna ha insegnato loro è stato vedere il nostro familiare pianeta terra in modo diverso.
Mentre si libravano sopra la terra, non potevano smettere di fissarne il mistero, vedendolo di nuovo in tutta la sua interconnessa bellezza, unità e fragilità, per la prima volta. Questa sorprendente rivelazione ha fornito loro utili #intuizioni per apprezzare, e fare diversamente le cose, una volta tornati a casa.
Non c’è chiaramente bisogno di andare sulla luna per riscoprire la terra, per fortuna. Possiamo, in qualsiasi momento, fermarci per osservare le nostre routine, le nostre risposte emotive e mentali predefinite a ciò che sperimentiamo, e sottoporle a un’ispezione compassionevole ma feroce.
A cosa servono? In che modo ci forniscono risorse e in che modo (specialmente nei tempi che cambiano) potrebbero essere disfunzionali?
LE ABILITA’ PER GUIDARE IL CAMBIAMENTO
Due sono le abilità essenziali correlate al successo nel guidare il cambiamento:
– una interiore (dell’essere): la capacità di entrare in sintonia con il sistema e percepire una causalità più profonda dietro ciò che vediamo in superficie. Portare la percezione sistemica a ciò che normalmente sperimentiamo può essere intellettualmente impegnativo, ma può portare a una sorprendente reinterpretazione del modo familiare di vedere le cose.
– una esteriore (del fare): la pratica of edge and tension leadership, in cui i leader possono parlare in modo chiaro e inequivocabile della realtà e, in particolare, sfidare le convenzioni e le routine comportamentali comuni. Rendere ciò che è familiare, strano.
L’AD che ha deciso di modificare i badge, ha usato entrambe le abilità, insieme. Non ha criticato i partner presenti alla conferenza quando hanno ripetutamente riscritto ruolo e titoli sui badge (è così facile personalizzare l’esperienza e vederla come un problema attitudinale o di abilità). No. Ha piuttosto interpretato questa routine familiare come un segnale sistemico della cultura che richiedeva ancora un cambiamento. Questo gli ha permesso di dispiegare poi visibilmente edge and tension con grande sensibilità.
L’AD ha aperto la conferenza con la storia del badge, evidenziando ciò che ancora richiedeva un cambiamento nella cultura – e ha chiesto a ogni leader presente di guardarsi dentro e riconoscere il disagio che viveva conseguentemente al rovesciamento della gerarchia: “il modo in cui funziona il badge, è rappresentativo del modo in cui si esplicita la vostra leadership quotidiana?’
Un approccio semplice ma di impatto, che ha permesso di rendere strano ciò che fino a quel momento era familiare.
TO DO
Per rendere strano ciò che è familiare occorre:
- Formare e coinvolgere osservatori interni. Troppo spesso inseriamo il pilota automatico, senza mai fermarci a osservare gli schemi nei quali siamo coinvolti. Tali osservatori distaccati e imparziali possono essere potenti specchi della cultura, capaci di premere il pulsante pausa di volta in volta in una riunione e condividere le loro osservazioni su ciò che stanno notando e ipotizzando. Tale approccio è utilissimo per cambiare le routine del momento.
- Portare le persone dalle familiari realtà lavorative in #contesti in cui il futuro sta già emergendo. Contesti diversi, stimolanti e che possono aiutare a guardare la cultura aziendale sotto una nuova luce, meno stereotipata e difensiva. Questo è un ottimo modo per incentivare l’innovazione.
- Raccogliere le intuizioni e le idee dei nuovi arrivati. Qualcuno ha detto che “la cultura aziendale è ciò che smetti di notare dopo tre mesi che la respiri e vivi tutti i giorni“. Dopo quel tempo, quello che sembrava strano all’inizio si è fatto routine, tra l’altro senza nemmeno essertene accorto. Incoraggio sempre i senior a confrontarsi con i nuovi arrivati per capire cosa sembra bizzarro della cultura aziendale.
Oltre a mettere in discussione le routine culturali quotidiane e sottoporle a ispezione imparziale, rendendo strano ciò che è familiare, gli antropologi sono addestrati a rendere normale ciò che potrebbe sembrare bizzarro di una cultura. Tutti i pensieri e le azioni possono avere perfettamente senso se visti attraverso gli occhi della cultura che li ha creati.
Come possono i leader del cambiamento introdurre nuovi modi di pensare e agire senza che la cultura “nativa” respinga questo sforzo?
Occorre conoscere da dove parte il sistema, e capire qual è il punto di disagio accettabile a cui si può spingere la cultura di quella specifica realtà (cosa che il mio osteopata fa magnificamente quando ho mal di schiena, sapendo quanta manipolazione è necessaria per portarmi beneficio ma senza causare danni).
IN CHE MODO?
C’è un altro video che può venire in soccorso: First Follower: Leadership Lessons from Dancing Guy. A un festival musicale si vede una persona uscire dalla folla e iniziare, da sola, a ballare in modo strano. Dopo un po’, un tizio lo raggiunge e appena inizia anche lui a ballare, il primo ballerino non appare più così strano, e presto l’intera folla si unisce ai due. Ciò che inizialmente era strano è diventato il nuovo familiare.
Il segreto è quindi quello di trovare e coltivare persone che non hanno paura di sperimentare, conoscere per ingaggiare tutti gli altri. In questo modo, qualsiasi novità che inizialmente sembra strana diventa, per riprova sociale e imitazione, ok.
Di fatto per incentivare il cambiamento occorre essere in grado di dare un #posto e uno #scopo alle diverse esperienze, in particolare a quelle che sembrano difficili, strane e bizzarre. Normalizzando poi in modo #acritico e non reattivo ciò che è scomodo (d’altronde, quale cambiamento avviene senza alcun disagio?), così da consentire alle persone di abituarsi a ciò che non è familiare. Nonché la capacità di rimanere curiosi e non ansiosi, anche in situazioni difficili e spigolose. Se il leader non si sente al sicuro con lo strano, allora nessun altro lo sarà.
SPUNTI PRATICI
Altri spunti pratici per “rendere familiare lo strano” e quindi aumentare le possibilità che un’organizzazione accetti e non rifiuti il cambiamento:
- Presenta il nuovo come naturale evoluzione del vecchio. Quando Edison lanciò l’elettricità negli Stati Uniti, progettò il suo nuovo sistema di illuminazione sulla falsariga dei precedenti sistemi di illuminazione a gas, in particolare le lampade a vista, in modo che le persone non rifiutassero ciò che era nuovo e possibilmente pericoloso.
- Inizia in piccolo e poi dai slancio al nuovo con interventi che si ripetono e creano la strada verso nuovi atteggiamenti e routine.
- Vai a caccia dei positive deviance: in ogni comunità ci sono persone dai comportamenti e dalle strategie insolite ma vincenti che consentono di trovare soluzioni migliori a una sfida di cambiamento rispetto ai loro coetanei, pur trovandosi nello stesso #contesto e con le stesse #risorse. Lo strano può sembrare più familiare quando ci si rende conto che sta già funzionando con buoni risultati nel proprio sistema.
Nel guidare il cambiamento occorre guardare alle differenze con rispetto. La differenza porta valore, non lo sottrae. E rendere il familiare strano e lo strano