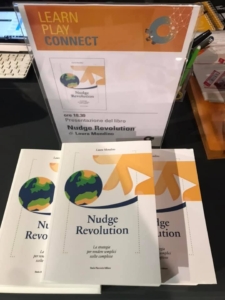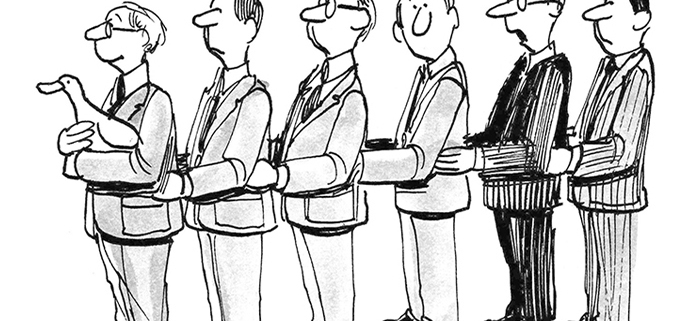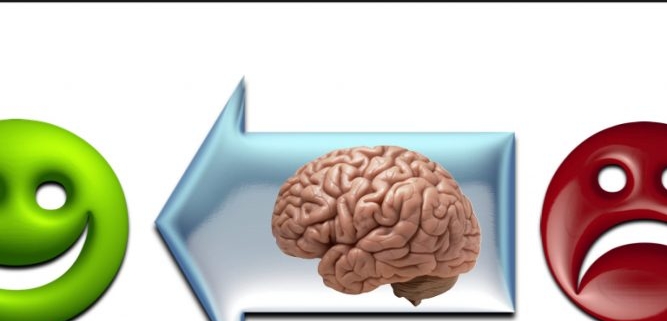“Life is what happens to you while you’re busy making other plans” cantava John Lennon, in Beautiful boy, il brano dedicato al figlio. La vita è proprio ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti…
Progetti è, guarda caso, la parola chiave di ogni fine e inizio anno, periodo durante il quale si rimugina sui fallimenti e/o si pianifica il futuro. Se ci pensiamo bene però, la nostra vita non si svolge secondo i nostri desiderata. Difficilmente riusciamo a prevedere ciò che ci renderà felici, poiché perdiamo molto di quello che ci accade sequestrati dalle attese che facciamo su ciò che deve accadere e su noi stessi. Molto di ciò che viviamo e sentiamo si colloca al di fuori della portata della coscienza.
Molti dei proposti, così come i bilanci, sono pieni di giudizi. Si soffermano su ciò che non è andato o mancato. Ecco perché alcuni studi dicono che i buoni propositi per il nuovo anno hanno in genere vita breve. Sono perfettamente inutili.
Al di là della bontà della pianificazione degli obiettivi, che sinceramente mi hanno un po’ stancato, non posso non pensare al libero arbitrio e a quanto sosteneva il biologo molecolare britannico, Francis Crick secondo cui “le neuroscienze contraddicono la nozione di libero arbitrio”. Anche il semplice atto di prendere un foglio dalla scrivania, è sostenuto e preceduto da complessi processi biochimici che avvengono al di sotto del livello di coscienza.
LIBERO ARBITRIO
Per quanto dibattuta e ambigua, la nozione di libero arbitrio è incentrata sul valore della libertà di scelta e sull’idea che chiunque, attraverso l’impegno e il sacrificio, possa raggiungere i propri obiettivi a prescindere dalle condizioni iniziali. Ma fin dalle teorie sull’evoluzione elaborate da Charles Darwin, è noto almeno dalla seconda metà del diciannovesimo secolo che le stesse facoltà intellettive alla base delle nostre scelte razionali siano almeno in parte un’eredità biologica e che, allo stesso tempo, il loro sviluppo sia condizionato da molteplici fattori ambientali. A seconda di quale dei due aspetti si consideri prioritario rispetto all’altro, la discussione tra addetti – neuroscienziati, filosofi, neurofisiologi e psichiatri – tende a oscillare tra due poli opposti rappresentati dal concetto di “natura” (l’eredità biologica) e da quello di “cultura” (i condizionamenti ambientali).
Tornando a Crick “Sei consapevole di una decisione, ma non sei consapevole di ciò che ti fa prendere la decisione. Ti sembra ovvio, ma è il risultato di cose di cui non sei a conoscenza”. Sapendo che sono in molti a negare il libero arbitrio, Crick studiò con attenzione gli esperimenti condotti dallo psicologo Benjamin Libet. Libet aveva chiesto alle sue cavie di premere un pulsante in un momento a loro scelta, segnando il momento della decisione su un orologio. Le loro onde cerebrali, monitorate da elettroencefalogramma (EEG), mostravano un picco di attività quasi un secondo prima che i soggetti decidessero di premere il pulsante. Questo e altri risultati mostrano, secondo Crick, che le nostre decisioni coscienti sono letteralmente ri-pensamenti.
Grazie a ulteriori esperimenti che non vi tedierò illustrandoli, due scienziati cognitivi Daniela Schiller e David Carmel scoprirono che “nel cervello ci sono neuroni che sanno che stai per fare un movimento un secondo prima che lo sappia tu stesso (Scientific American). Si potrebbe essere tentati di concludere che il libero arbitrio è un’illusione”.
Ovviamente questi esperimenti sono insufficienti per sondare il libero arbitrio, poiché le cavie avevano già preso la decisione di premere il pulsante; hanno solo scelto quando farlo. Ci sarebbe da sorprendersi se i sensori EEG non avessero trovato un’anticipazione neurale di quella scelta.
Diversi sono gli studi con elettrodi impiantati nel cervello che rivelano come inganniamo noi stessi nel pensare di avere il controllo quando non lo abbiamo. Gli scienziati, per esempio, possono far alzare il braccio di un paziente stimolando elettricamente un punto nella corteccia motoria. Spesso il paziente sostiene che intendeva sollevare il braccio e addirittura inventa un motivo. Nel libro The Illusion of Conscious Will, lo psicologo Daniel Wegner chiama confabulazioni queste spiegazioni deliranti successive all’evento.
Noi tutti confabuliamo. Facciamo passivamente ciò che ci è stato detto di fare e crediamo a quello che ci è stato detto di credere da genitori, formatori, sacerdoti e leader politici, e ci convinciamo che è una nostra scelta. Sovvertiamo la nostra volontà per arrivare in modo insincero a una conclusione scontata, fallendo nell’agire sulla base delle nostre risoluzioni. A volte agiamo seguendo un impulso – paura o rabbia – senza pensare alle conseguenze delle nostre azioni. Ma non significa che la volontà non esista.
Il filosofo Daniel Dennett nel libro L’evoluzione della libertà osserva che il libero arbitrio non è “quello che la tradizione afferma che sia: un potere quasi divino di astrarsi dal tessuto causale del mondo fisico”. Il libero arbitrio è la capacità di percepire, riflettere e mettere in atto delle scelte; infatti, scelta, o addirittura libertà, sono sinonimi ragionevoli di libero arbitrio.
Dennett chiama il libero arbitrio “una creazione evoluta delle attività e delle credenze umane”, che l’umanità ha acquisito recentemente come conseguenza del linguaggio e della cultura. Il libero arbitrio è una proprietà variabile che può crescere e diminuire sia negli individui sia nelle società: più scelte possiamo percepire e fare, più libertà avremo.
Noi, a nostra volta, siamo dipendenti dal libero arbitrio. Il concetto di libero arbitrio è alla base di tutta la nostra etica e morale: ci costringe ad assumerci le nostre responsabilità invece di consegnare il nostro destino ai nostri geni o a un piano divino. Le scelte, fatte liberamente, sono ciò che dà significato alla vita. Provate a dire ai prigionieri di Guantanamo o ai civili afgani, siriani e via dicendo in fuga da bombe e proiettili che le scelte sono illusorie. “Scambiamoci i ruoli”, potrebbero rispondere, “visto che non avete nulla da perdere.”
Alcuni studi inoltre dimostrano che “Le persone portate a credere meno al libero arbitrio hanno maggiore probabilità di comportarsi immoralmente”. E’ come se le persone private della convinzione della propria autodeterminazione smettessero allo stesso tempo di sentirsi responsabili delle proprie azioni.
ILLUSIONE O REALTA’?
Pur essendo ragionevolmente convinto che il libero arbitrio sia un concetto infondato, Saul Smilansky, docente di filosofia all’Università di Haifa, in Israele, sostiene che sia meglio vivere con l’“illusione” che esista qualcosa di simile, piuttosto che favorire la diffusione del determinismo. Secondo Smilansky, l’idea che ciascun individuo non abbia possibilità di autodeterminarsi non soltanto potrebbe creare i presupposti di una tendenza alla deresponsabilizzazione, ma annullerebbe automaticamente anche qualsiasi idea di merito individuale.
Se un uomo rischiasse la vita paracadutandosi in territorio nemico per portare a termine una coraggiosa missione. In seguito la gente dirà che non ha avuto scelta, che l’impresa, per dirla come Smilansky, è stata soltanto “il dispiegamento di un dato di fatto”, e perciò difficilmente encomiabile. E così come l’eliminazione delle responsabilità eliminerebbe un ostacolo ad agire in modo malvagio, l’eliminazione degli elogi eliminerebbe un incentivo a fare le cose bene.
Secondo i sostenitori di questa forma di “illusionismo” filosofico, la fiducia nel libero arbitrio potrebbe spronarci a tirare fuori il meglio da noi stessi. E Smilansky, che ritiene questa fiducia del tutto connaturata nell’essere umano, crede che le istituzioni fondate sul presupposto stesso del libero arbitrio – tutte quelle che amministrano la giustizia, per esempio – siano assolutamente necessarie per evitare di finire nell’estrema barbarie.
MEGLIO SENZA?
Altri studiosi, non credono che abbandonare il concetto di libero arbitrio possa avere effetti nocivi sul grado di civiltà di una società. Il neuroscienziato Sam Harris, crede che sarebbe molto meglio farne a meno, e che le nostre credenze debbano sempre seguire ciò che si dimostra essere vero. “Come società, dovremmo conoscere quali sono le leve da azionare per incoraggiare le persone a essere le migliori versioni di sé che possono essere”. Secondo lui, se accettassimo che “il comportamento umano emerge dalla neurofisiologia” potremmo più facilmente comprendere cosa davvero spinge le persone a compiere azioni dannose e provare a impedire che questo accada, piuttosto che usare punizioni come il carcere come deterrente.
Per comprenderne i benefici, prosegue Harris, basta confrontare due catastrofi di scala simile: le reazioni alle morti causate dall’uragano Katrina furono molto diverse dalle reazioni alle morti causate l’11 settembre. Nel primo caso, nessuno se la prese con le tempeste tropicali o dichiarò una Guerra al Clima, e la risposta collettiva all’uragano poté concentrarsi sulla ricostruzione e sulla prevenzione. Nel secondo caso, l’ottenebramento generato dal desiderio di vendetta portò a un’ulteriore, non necessaria, perdita di innumerevoli vite.
A voi, in un tempo di bilanci e costruzione di nuove aspettative, lascio l’ultima parola, la possibilità di credere o meno alle mie tante confabulazioni e delineare ciò che è scienza e ciò che è mal riposta credenza.
Buon anno!