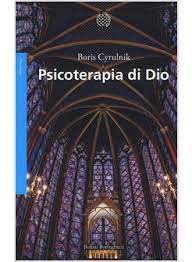Le TRAPPOLE della (MALA) SCRITTURA
Non è facile far percepire il valore dello scrittore (professionista). Che si tratti di scrivere un articolo, un libro, una Newsletter o post per blog e social. Tutti sanno costruire frasi, ecco perché è facile improvvisarsi copy, ghostwriter e scrittori e millantare capacità letterarie poi non coerenti con i risultati portati a casa e sostenibili nel tempo.
Scrivere male è infatti assai più facile e più frequente dello scrivere bene. Per appropriarti dell’arte della scrittura l’unico modo è leggere tanto e scrivere di più. Migliorarsi è possibile ma non è nè facile nè rapido.
Inoltre ogni volta che ci si cimenta nella stesura di un libro o di un articolo alcune trappole mentali si materializzano come d’incanto per rendere l’impresa ancor più ardua. Quali?
LA TRAPPOLA DELL’AUTOCOMPIACIMENTO
E’ la credenza di avere la verità in tasca, di pensarsi migliori di tutti. E questo porta a una scrittura pessima, autoreferenziale, cieca ai bisogni di chi legge e di chi cerca risposte e soluzioni. Questo stile può funzionare quando si tratta di tomi universitari o di temi complessi, in tutti gli altri casi è un suicidio. La scrittura è ben altro: è la capacità di aprirsi agli altri, di confrontarsi e ascoltare le idee del mondo. Non c’è peggior scrittore di chi crede di essere Tim Roth, Martin Amis o Umberto Eco e di poter dire la sua senza ascoltare nessuno. In questi casi è meglio limitarsi a scrivere un diario da tenersi rigorosamente in un cassetto.
LA TRAPPOLA DELL’INSICUREZZA
Chi è insicuro o costellato di dubbi tende a scrivere male in quanto non vuole esporsi, vuole rimanere al sicuro nella propria zona di comfort. E finisce con trattare tematiche in modo superficiale e asettico, facendo di tutto per nascondere il proprio tratto distintivo, la propria firma, il proprio stile. Senza emozioni non c’è storia che vale la pena essere vissuta.
LA TRAPPOLA DELLA MONOTONIA
Come nella vita di tutti i giorni, anche nella scrittura tendiamo a proporre i soliti schemi, le nostre rassicuranti ed automatiche routine.
Nel caso della scrittura il rischio è di appiattire la trama, risultando noiosi e poco emozionali. Scontati. Confrontarsi con altri stili e leggere molto è sempre il miglior consiglio per appropriarsi di più stili e di una leggerezza narrativa raramente innata.
SCRIVERE E’ UN LAVORO PER POCHI
Scrivere è dunque un lavoro per pochi. Coloro che si mettono in gioco. Che conoscono la grammatica, la sintassi, le regole della leggibilità. Scrivere in modo errato “qual è” o “anch’io” sono errori che si possono correggere, più difficile è il rapporto con se stessi e il proprio pubblico. Non per nulla molti abbandonano o continuano a scrivere male, schermandosi dietro scuse e l’arroganza di chiamare stile personale, una schizofrenia di parole buttate a caso come tessere di un puzzle su un foglio bianco.
Scrivere è un lavoro. E come tale non può essere improvvisato.